Le relazioni oggettuali nella teoria psicoanalitica: da Freud alla scuola inglese di psicoanalisi
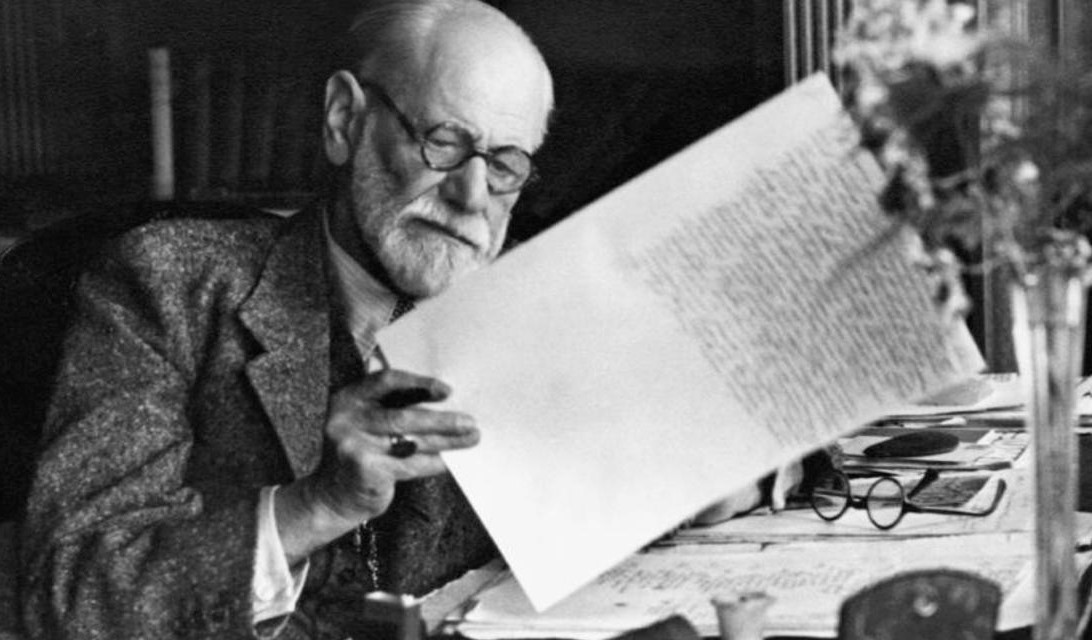
Generalmente quando parliamo di oggetto e di relazioni oggettuali ci riferiamo a rappresentazioni di persone all’interno della nostra mente. Nel libro Da Freud alla psicoanalisi contemporanea, Morris Eagle riporta un’osservazione di Ronald Laing che allude confusione intrinseca all’uso del termine oggetto: “È ancora di oggetti che si scrive e non di persone”. Il fraintendimento, osserva Morris Eagle, dipende dal fatto che il termine oggetto si riferisca a significati molteplici e complessi. Nel corso della riflessione psicoanalitica il termine oggetto è stato utilizzato in riferimento a:
– Un oggetto fisico reale, che può essere una persona o un qualcosa di inanimato.
– La rappresentazione mentale di una persona o di una relazione con una persona.
– L’introiezione del Super-io, inteso come la somma dei valori, delle credenze, e degli atteggiamenti mutuati dal rapporto con le figure genitoriali. In questo caso si può parlare di introietto, cioè qualcosa non del tutto assimilabile al sé.
Nel saggio Pulsioni e loro destini del 1915, Freud utilizzava il termine oggetto al posto di persona per riferirsi “a ciò in relazione a cui, o mediante cui, la pulsione può raggiungere la sua meta”. Per Freud è di primaria importanza che la pulsione raggiunga la scarica, ed è proprio grazie all’oggetto che è possibile ridurre la tensione derivante della spinta pulsionale. In questa visione l’essere umano non è intrinsecamente orientato verso gli oggetti, ciò verso gli altri, ma si rivolge ad essi con riluttanza, motivato dal bisogno di scaricare l’eccitamento pulsionale e raggiungere la gratificazione. Per Freud, quindi, l’essere umano presta la sua attenzione al proprio simile in modo del tutto secondario ed indiretto: una visione del tutto solipsistica dell’uomo.
Nella visione freudiana, il neonato deve superare la sua iniziale reazione di “repulsione” e di “odio” verso l’oggetto che va ad infrangere uno stato originario di quiete, introducendo un eccitamento indesiderato. Il padre della psicoanalisi immagina che il neonato tenti invano di ridurre le tensioni pulsionali derivanti dalla fame mediante l’allucinazione del seno materno. A seguito di questo fallimento, l’infante è costretto a rivolgersi alla madre per ottenere un reale appagamento dei suoi bisogni. Sia Freud che sua figlia Anna ritenevano che fosse la riduzione della pulsione della fame del piccolo ad incentivare l’attaccamento tra madre e bambino. Gli stimoli capaci di ridurre le tensioni pulsionali primarie, come la fame, assumono proprietà pulsionali rinforzanti e secondarie. In altre parole, la madre assume proprietà pulsionali secondarie perché viene associata alla scarica di pulsioni primarie. Questo concetto, la teoria della pulsione secondaria, è il punto che più verrà criticato e da cui verrà costruita la teoria delle relazioni oggettuali.
Nel lavoro di Freud c’è un’altra situazione in cui è possibile osservare il ruolo secondario dell’oggetto. In Introduzione al narcisismo (1914) Freud conia l’espressione “narcisismo primario” per indicare lo stato in cui ci troviamo all’inizio della vita, in cui tutta la pulsione è investita sull’io. Infatti, la sessualità infantile “non conosce ancora un oggetto sessuale, è autoerotica”. Successivamente, se la libido non viene investita sugli altri si rischia un sovrabbondante eccitamento dell’io, che si esaurisce. Freud suggerisce che siamo costretti ad amare, ad investire sugli altri se non ci vogliamo ammalare. Anche se riconosce il ruolo centrale dell’altro per l’io, l’oggetto è sempre secondario e mai primario.
Come abbiamo visto la proposta di Freud è coerente con la teoria delle pulsioni, ed è ben riassunta da queste parole di Morris Eagle: “Le pulsioni sono ciecamente alla ricerca della scarica, e inizialmente la perseguono mediante l’appagamento allucinatorio del desiderio basato sul processo primario, senza il coinvolgimento di un oggetto reale indipendente. L’oggetto reale entrerà nel quadro soltanto grazie agli insegnamenti dell’emergente principio di realtà”.
Sono proprio queste le idee freudiane che saranno al centro dello scontro e daranno il via ai successivi sviluppi delle psicoanalisi. Alcune critiche alla teoria pulsionale secondaria di Freud si trovano già a partire dagli anni Trenta. Imre Hermann nel 1933 aveva ipotizzato che nei neonati esistesse una componente primaria dell’attaccamento. Hermann faceva parte della scuola ungherese di psicoanalisi insieme a Sandor Ferenczi. Nel 1935, un altro psicoanalista, Ian Suttie, aveva dato enfasi alla natura intrinsecamente relazionale dell’essere umano, cioè al fatto che siamo filogeneticamente portati ad entrare da subito in relazione con l’altro. Una simile visione dell’uomo è stata assimilata soltanto dalle psicoanalisi contemporanee e oggi tendiamo quasi a darla per scontata, ma negli anni trenta rappresentò una posizione più che minoritaria.
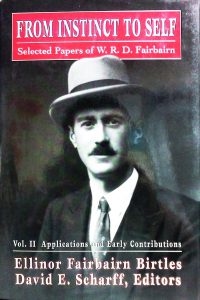
Ronald Fairbairn e gli sviluppi del concetto di oggetto in psicoanalisi
Tra gli anni quaranta e gli anni sessanta, analisti come William Ronald Dodds Fairbairn, Michael Balint, Donald Winnicott, Masud Khan, Matte Blanco e John Bowlby (solo per citarne alcuni) metteranno in discussione inesorabilmente le idee di Freud. Queste figure di spicco, all’interno della Società britannica di psicoanalisi, prenderanno le distanze dalla diatriba in corso tra Anna Freud e Melanie Klein, formando il cosiddetto middle group, al cui interno si svilupperà la loro particolare visone delle teoria delle relazioni oggettuali.
Secondo Morris Eagle, quella di Ronald Fairbairn è la visione più completa e sistematica delle relazioni oggettuali che si possa trovare all’interno della riflessione psicoanalitica. Dal suo osservatorio clinico di Edimburgo, Faribairn ribalta il sistema motivazionale utilizzato da Freud, assegnando all’oggetto un ruolo primario e ritenendo il piacere un mezzo per arrivare all’altro. Il bambino ha bisogno fin dalla nascita degli altri e si predispone autenticamente verso di loro, sostenuto dalla libido. Il piacere non è il fine da perseguire, ma la conseguenza del raggiungimento di un rapporto positivo con l’altro essere umano. Fairbairn sostiene infatti che «la libido non è primariamente pleasure-seeking, ma object-seeking».
Il bambino è quindi orientato all’esterno e tutto il suo comportamento è basato sulla ricerca e sul mantenimento del contatto con gli altri. L’energia necessaria per questa ricerca è fornita dalla libido, che lo orienta naturalmente verso l’altro. Quella di Fairbairn è una vera e propria svolta, a cui seguirà nel tempo un lento ma costante riconoscimento della natura relazionale umana. Lo psicoanalista scozzese si interessa alle relazioni reali che il bambino intrattiene con gli altri, la madre in primis, e ai risvolti che queste possono manifestare nella mente del piccolo. Lo sviluppo e la formazione della personalità sono strettamente correlati agli scambi del bambino con la madre e con le persone reali.
Queste interazioni con l’altro possono essere caratterizzate da amore, gioia, felicità, cooperazione, aiuto, fiducia, ma anche da rabbia, frustrazione, rivendicazione e al limite da aggressività e da violenza fisica. Secondo il pensiero di Fairbairn, quando il bambino sperimenta interazioni positive col caregiver, queste vengono interiorizzate nel sé senza problemi, sotto forma di ricordi ed emozioni positive. Quando invece il bambino è sottoposto a violenza e a maltrattamento, la natura traumatica e dolorosa delle sensazioni e dei ricordi prodotti, fa sì che questi non possano essere integrati all’interno del sé. Quindi la persona sperimenta una “presenza”, una “voce” interna a lui ma estranea, una sorta di “sabotatore interno” che lo critica e lo rifiuta. Morris N. Eagle utilizza la metafora della digestione per spiegare questo concetto: infatti se i cibi buoni che mangiamo vengono assimilati e i loro contenuti andranno a fare parte delle nostre cellule, i cibi cattivi saranno indigeribili e non potranno essere metabolizzati proprio come le esperienze di violenza subita. Gli oggetti cattivi interni si costituiscono a partire da interazioni reali esterne negative con il caregiver.
E’ interessante notare come questo concetto di Fairbairn si avvicina a quello di sé alieno che verrà proposto da Peter Fonagy negli anni novanta: una presenza che colonizza il sé e da cui ci si vorrebbe liberare in tutti i modi, al limite attaccando sé stessi. Fonagy avanzerà una spiegazione del suicidio nei casi più gravi di Disturbo Borderline di Personalità come il tentativo estremo di liberarsi da un sé alieno particolarmente potente.
Tornando al lavoro di Fairbairn, nel caso in cui il bambino interiorizzi un oggetto cattivo a partire dall’esperienza reale di interazione, egli sarà portato ad attribuire la cattiveria a se stesso per salvare l’oggetto. Per un bambino sarebbe intollerabile vivere con un genitore rappresentato come rifiutante e cattivo e, pur di sopravvivere, questa cattiveria viene attribuita al sé: quando “il rifiuto e la mancanza di amore possono essere attribuiti alla propria cattiveria, c’è la speranza che, essendo buoni, si possa riconquistare l’amore dei genitori” (Morris N. Eagle). In questo caso il meccanismo che permette di salvare l’oggetto è l’idealizzazione: il genitore viene rappresentato in maniera positiva e perfetta, del tutto incompatibilmente con le esperienze reali di interazione. Otto Kernberg a metà degli anni settanta osserverà che l’idealizzazione diventa funzionale a stemperare l’aggressività verso l’oggetto, rendendo possibile una rappresentazione positiva dello stesso. Secondo Fairbairn, l’interiorizzazione dell’altro è necessaria a sostenere l’io ed evitare la situazione tragica di un mondo interno vuoto, privo di relazioni con gli oggetti.
Per lo psicoanalista scozzese un tratto distintivo della patologia è quello di proiettare i propri oggetti interni sulle persone reali. Uno degli scopi della terapia è quello aiutare il paziente a interagire con le persone reali per quello che realmente sono. Per Fairbairn la sofferenza mentale è caratterizzata dall’impossibilità dell’io di intrattenere relazioni reali gratificanti, a causa del frapporsi degli oggetti interni negativi.
Bibliografia
Morris Eagle (2012), Da Freud alla psicoanalisi contemporanea. Milano: Raffaello Cortina Editore
